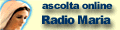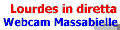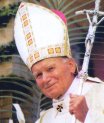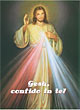|
Data pubblicazione: martedì 22 ottobre 2002
|
|
RUBRICHE - SAGGI DI STORIA CALABRESE
Le chiese di Monteleone alla fine del XVI secolo
La città di Monteleone, sulle falde nord-orientali del massiccio del Monte Poro, ebbe il nome lati-no di Vibo Valentia con decreto reale del 4 gennaio 1928. La legge n. 249 del 6 marzo 1992 la elevò a capoluogo di provincia con giurisdizione su cinquanta comuni già appartenenti alla provin-cia di Catanzaro.
Lo stato delle chiese nel XVI secolo, quando con una popolazione di 2.192 fuochi o famiglie contava intorno ai 6.600 abitanti ( 1), è noto dai verbali della visita pastorale effettuata nei giorni 10 e 11 giugno 1586 dal vescovo di Mileto mons. Marcantonio del Tufo ( 2) e dalle notizie riportate nelle monografie di storia locale.
In quell’epoca l’unica chiesa parrocchiale era quella di Santa Maria la Grande, officiata da sette rettori porzionari ( 3). Secondo lo storico Bisogni, che scriveva nel 1710, questa chiesa era divenuta parrocchiale dopo che la città era stata incendiata e distrutta dai saraceni intorno all’anno 983 ( 4).
Questa condizione di parrocchiale è in netto contrasto con quanto asserito sia nel passato che in anni non molto lontani da alcuni storici monteleonesi, i quali scrivevano che la sede della parroc- chia era nella chiesa di San Michele Arcangelo, alla quale interpretavano si riferisse la bolla emana-ta l’8 agosto 1519 dal papa Leone X per l’aumento da quattro ad otto del numero dei rettori porzio-nari che dovevano essere cittadini di Monteleone. Le rendite erano divise in otto parti uguali dette porzioni, e di queste ne percepiva due uno dei rettori ed una ciascuno gli altri sei ( 5).
Ma quel riferimento si rileva arbitrario ed infondato, perché nel documento pontificio è indicata una Parochialis Ecclesia senza alcuna specificazione di dedicazione. In realtà, come risulta da un’esplicita dichiarazione inserita nel verbale della visita pastorale, nella chiesa di San Michele si amministravano i sacramenti in quanto sta fuori dell’habitato di detta t(er)ra la chiesa parrocchiale di Santa Maria la Grande.
Nel pomeriggio del 10 giugno 1586 il vescovo iniziò la visita alle chiese di Monteleone recandosi per primo in quella di San Michele Arcangelo, dove ricevette l’obbedienza dai sette rettori della parrocchiale : Giannandrea de Alexandris con diritto a due porzioni, Andrea Manno, Minico Pia-cente, Saladino Alemanno, Vincenzo Pavone, Matteo (de) Nicastro, Giandomenico (di) Gennaro, che percepivano una porzione ciascuno.
Recitati i vespri, il vescovo si diresse all’altare maggiore, ornato di sei candelieri. In una custodia di legno, dorata all’esterno e tappezzata con tessuto di armosino carmosino (6) all’interno era riposto il Ss. Sacramento in un vaso d’avolio che fu ordinato di sostituirlo con uno di argento entro due mesi.
Nell’altare, consacrato come pure la chiesa essendoci le croci ed i sigilli, era eretta la confraternita del Santissimo Sacramento. Il pontefice Paolo III con bolla del 30 novembre 1539 estese a questa i privilegi e le grazie già concessi ai confratelli dell’Immagine del Santissimo Salvatore di San Gio- vanni in Laterano ed a due istituzioni caritative romane, e con altra del 6 aprile 1548 l’aggregò alla primaria con sede in Roma. In quell’anno erano procuratori il sig. Carlo Solano ed il notaio Bartolo (de) Onemma, e cassiere Giangirolamo Silvestri. Per la verifica del rendiconto alla fine dell’ammi- nistrazione annuale fu dato incarico al rettore Matteo (de) Nicastro.
Sopra la custodia era posto un quadro di tela con la raffigurazione dell’eschiovatura di Cristo dal- la croce. Tre lampade nei giorni feriali e cinque nei festivi stavano accese davanti al tabernacolo a spese e cura della confraternita.
In una cassa di noce erano conservati i sacri arredi : l’ostensorio, due lanternoni, quattro messali, una serpellizza, venticinque tovaglie tra grandi e piccole, tre pallii e quindici mazze di legno dorato, due stendardi di damasco, uno bianco e l’altro rosso, sei càmici completi di amitti e di cingoli, un piviale di damasco, una pianeta di velluto nero ed una di damasco giallo, e due cappelle di damasco, una rossa ed una verde, comprendenti ciascuna un avantaltare, una pianeta, due dalmatiche, un piviale, e le stole ed i manipoli.
Oltre all’altare maggiore nella chiesa ce n’erano altri sette non consacrati, tre da una parte e quattro dall’altra, di nessuno dei quali fu indicata il santo titolare.
La sagrestia necessitava del lavatorio, e fu ordinato di provvedere entro quattro mesi e di porre anche un asciugamani per uso dei sacerdoti dopo essersi lavati. Nella navata c’era la pila con l’acqua santa.
Terminata la visita in San Michele, il vescovo si avviò verso la chiesa parrocchiale di Santa Maria la Grande, ubicata all’estremità nord-est della città.
Sull’altare maggiore, non consacrato, c’era una Madonna di Relevo di legno con doi angelelli accanto. Tre tovaglie e l’avantaltare o paliotto di damasco bianco, e sei candelieri due dei quali d’ottone e due di legno ne completavano l’ornamento.
Il fonte battesimale, simbolo della dignità parrocchiale, mostrava l’incuria dei rettori. L’acqua benedetta era contenuta in un vaso di argilla, probabilmente senza custodia. Infatti il vescovo ordinò sotto pena a suo arbitrio riservata di provvedere entro quattro mesi di un vaso di marmo o di altra pietra dura ( 7) per conservare l’acqua benedetta per l’amministrazione del sacramento del battesimo. Nella stessa prescrizione era compreso l’obbligo di fare il coperchio di legno rivestito dalla parte inferiore con lastre di rame stagnato, ed una truglia seu cupola di tavole con sportelli e chiusura a chiave.
L’arredamento comprendeva una croce d’argento antica col velo di damasco carmosino, un ostensorio di rame all’antica con guarnimenti d’argento ( 8), un incensiere d’argento del valore di cinquanta ducati, una immagine antica d’argento della Madonna del valore di ottanta ducati, tre calici con le coppe e due patene d’argento. Le due cappelle erano una d’imbroccatello di seta gialla e verde e l’altra di damasco bianco, entrambe incomplete perché mancanti la prima del piviale e l’altra anche della stola e del manipolo. Inoltre per il servizio liturgico la chiesa disponeva di quattro pianete, delle quali una con lo stemma della famiglia Giffoni donatrice, di tre piviali, di due messali, di due dalmatiche, di un avantaltare, di sette càmici con relativi amitti e cingoli, di cinquanta tovaglie grandi e piccole, di un pallio vecchio di damasco verde, e di una cultra di taffità.
Sotto pena arbitraria, entro cinque mesi rettori dovevano provvedere di un crocefisso di legno per l’altare maggiore, e di un avantaltare e di una pianeta di seta di colore paonazzo.
Il vescovo visitò quindi l’altare non consacrato dedicato a San Nicola, che era di juspatronato del chierico Gianferrante Salerno con l’obbligo della celebrazione di una messa ogni settimana ( 9). Il cappellano sostituto era il rettore Andrea Manno, che fu condannato alla pena prevista negli editti per non essere stato presente al rito della visita.
Rilevata la mancanza di un quadro del santo titolare, di un crocefisso di legno sull’altare, e di uno sgabello anche di legno, sotto pena arbitraria fu ordinato di provvedere entro due mesi.
Patronato della magnifica Sana Gagliando di Francica, erede del fu magnifico Gabriele Solano, era l’altare di Santa Maria della Croce, con il peso della celebrazione di quattro messe ogni settimana. Il cappellano Saladino Alemanno, uno dei rettori della chiesa, era stato nominato con bolla del vescovo Gianmaria Alexandris del 13 settembre 1571.
Il non ricco arredamento comprendeva una pianeta di vellutello giallo e turchino con la stola ed il manipolo, un calice con coppa e patena d’argento, due càmici con gli amitti e i cingoli, un messale, tre tovaglie, e due avantaltari. Il cappellano fu obbligato a provvedere entro sei mesi l’altare di un quadro della titolare, con l’espressa riserva della condanna alle pene condecenti in caso d’inadempienza.
Non consacrato, come il precedente, era l’altare di Santa Maria degli Angeli. Patronato della famiglia Caratelli, originaria di Amantèa, era cappellano il sac. Lorenzo Guida della stessa città. Sufficientemente arredato, doveva essere dotato di un quadro della Madonna entro sei mesi.
Terminata la visita degli altari e constatata la presenza dell’acquasantiera nella chiesa e l’efficien-za delle quattro campane poste sul campanile, prescrisse di accomodare le sepolture.
I rettori furono invitati a compilare la tabella delle messe annuali, ed ammoniti che seguitano ad insegnare la doctrina Xpiana alli Populi affiati alle loro cure spirituali.
Il giorno successivo, l’11 giugno, il vescovo si recò nella chiesa di San Sebastiano nella quale l’altare maggiore non era consacrato. Ornato dall’avantaltare di panno paonazzo con le fasce di velluto nero e da tre tovaglie, da due candelieri e dalla carta-gloria, sopra era posto un quadro di tela dipinta con la Madonna, San Rocco e San Sebastiano, protetto da un guardapolvere di tela turchina. Inoltre c’erano due candelieri per porre le torce di cera durante l’esposizione del Santis-simo Sacramento (10) e lo sgabello di legno. Mancava il crocefisso di legno, che fu comandato di porre entro due mesi.
Il cappellano Tullio Mele dichiarò che la chiesa era di una confraternita di laici che partecipava alle processioni che si svolgevano nella città. Procuratore o mastro era Cola Migale, al quale fu fatto obbligo di presentare al vescovo od a chi per lui i conti alla fine dell’amministrazione. Per il controllo degli anni precedenti furono delegati con facoltà di condennare et liberare i rettori Matteo (de) Nicastro e Minico di Gennaro.
Quattro pianete con relative stole e manipoli, due calici con coppe e patène d’argento, quattro càmici con amitti e cingoli, due messali grandi ed altrettanti piccoli, nove tovaglie, un incensiere d’ottone, due stendardi di damasco, uno di colore rosso e l’altro verde, con le loro aste, due paia di ampolline, due campanelli piccoli, e due paia di candelieri di legno costituivano gli arredi per il culto.
Oltre all’altare maggiore ce n’erano eretti altri due, ciascuno con tovaglie e paliotto, uno rosso e l’altro giallo. Nella chiesa c’era la pila per l’acqua santa, ed una campana invitava i fedeli a partecipare alle divine celebrazioni (11).
Successivamente fu visitata la chiesa di Santa Maria del Soccorso, che dalla descrizione risulta essere all’epoca la più fastosa e la meglio arredata. L’erezione era recente, essendo avvenuta dopo che la confraternita del medesimo titolo in data 8 giugno 1563 aveva concesso la chiesa di Santa Lucia e l’orto contiguo per la costruzione dell’ospedale degli incurabili.
L’altare maggiore, non consacrato, era ornato dal crocefisso col piede d’ottone dorato, da un paliotto di Raso turchino picato con trene di oro e da tre tovaglie di seta, e da due candelieri di bronzo e due di legno. Davanti, ai lati, c’erano due candelieri di legno dorati per le torce di cera q(ua)n(do) si alza il Santissimo Sacramento. Sopra quest’altare una cona grande di legno guarnita ed indorata in molte parti, che doveva essere una nicchia, racchiudeva un’imagine della Madonna Sant(issi)ma del Soccorso di rilevo tra le figure ad olio dei santi Pietro e Paolo in basso e dei santi Giovanni e Rocco sopra e l’assumptione di N(ost)ro S(igno)re in mezzo. Quest’ultima scena rappresentava evidentemente l’ascensione di Gesù al cielo.
Nel corso della visita si presentarono i procuratori magnifico Gianfrancesco Fallacca e mastro Annibale Lanzo e dichiararono che la chiesa apparteneva ad una confraternita di laici (12), decorata con diverse indulgenze (13) delle quali in particolare una era stata concessa dal papa Gregorio XIII l’anno 1580.
Il ricco arredamento si conservava in quattro casse poste nella sagrestia, e fu dato in consegna ai sac. Marco Catania, Giovanni Cilea e Michele de Alessi, con la raccomandazione di servirsene come comanda la Santa Chiesa e di mantenerlo pulito. Il lungo inventario comprendeva : nove calici con le coppe e le patene d’argento, un crocifisso d’argento che si poneva sopra lo stendardo professionale, un instr(oment)o d’ottone per dar la pace ed un sicco (14) dove si da l’acqua benedetta ed anche un paio di ferri per la confezione delle ostie, due borse di damasco carmosino con trene dorate per conservare i corporali, due lanternoni grandi e due piccoli, tre stendardi di damasco turchino con la figura della Madonna, due cappelle di damasco incomplete, una bianca e l’altra di colore carmosino, dieci avantaltari ed undici pianete delle quali una con lo stemma della famiglia dei duchi Pignatelli offerente, di diversi tessuti e colori, un piviale di raso, cinquanta tovaglie d’altare, cinque càmici con gli amitti ed i cingoli, due messali grandi ed uno piccolo, e due libri di cantare che certamente erano degli antifonari.
Nella chiesa pavimentata e soffittata, e dotata di sepolture comode e di pila con l’acqua santa, erano eretti sette altari mancanti delle croci di legno. Non avendo rendite, in essi si celebrava con le offerte dei fedeli. Sul campanile erano poste due campane, una grande di circa cinque catara ed una piccola.
Si recò poi nella chiesa dello Spirito Santo, detta volgarmente delle orfanelle, che fu trovata in costruzione. I procuratori Marino Strongili e Pietrantonio Ferraro dichiararono che era già eretta una confraternita di laici.
Si officiava in una cappella accomodata per rimedio e si celebrava in un altare non consacrato ed ornato con tre tovaglie, col paliotto d’armosino verde e con quattro candelieri, sopra il quale era posto un quadro ad olio raffigurante il Crocefisso racchiuso in una cornice di legno. Sulla destra della porta d’ingresso, attraverso una grata di ferro le orfanelle assistevano alle funzioni religiose.
Si presentarono il governatore ducale, sig. Alfonso Aversano, ed i magnifici sig. Fabio di Falco, Geronimo Fuscandi e Scipione Mag(?)lia, l’u. i. dr Marcantonio Ferraro, il not. Bartolo (de) Onem- ma, per se stessi e per Nardo Garuffi (15) alfiere di casa Pignatelli.
La chiesa era annessa a un conservatorio di monache che professavano la “Regola” di Santa Chia- ra. In questo erano ospitate le figliole vergini che verosimilmente si dubita della loro deflorazione, nel rispetto della bolla di fondazione emessa il 13 gennaio 1579 dal pontefice Gregorio XIII in accoglimento di una petizione inoltrata dal duca Camillo Pignatelli e dai rappresentanti della città di Monteleone e dei suoi casali (16).
In una cassa vecchia si conservavano gli arredi sacri : un calice con la coppa e la patena d’argento, due càmici con gli amitti e i cingoli, un messale, quattro candelieri di legno, undici tovaglie e due cuscini di rezza di seta, una pianeta con la stola e il manipolo di armosino verde, e della stessa stoffa un avantaltare ed una borsa per custodire i corporali, due avantaltari di tela, uno bianco ed uno nero, ed un altro di cuoio, ed alcune bolle d’indulgenze.
Poco distante da questa chiesa era quella dei santi Nicola e Lucia, annessa all’ospedale degli incurabili, fornita di una campana sonante.
L’ornamento del non consacrato altare maggiore era costituito da tre tovaglie, da un avantaltare di armosino carmosino, da due candelieri di legno dorati, e da una statua di San Nicola di legno dorato. Si celebrava la messa tre volte la settimana ed in tutti i giorni festivi.
I sacri arredi non erano molti : un vecchio avantaltare di armosino, una pianeta con la stola ed il manipolo di armosino carmosino, due càmici con gli amitti ed i cingoli, uno stendardo d’armosino bianco, due calici con le coppe e le patene d’argento, un messale, una carta-gloria, due cuscini di armosino carmosino, un confessionale di legno, sei tovaglie d’altare, ed un campanello piccolo.
In origine dovevano essere due cappelle distinte e contigue, perché nel verbale della visita a proposito di Santa Lucia è riferito che prima era chiesa separata ed in atto era grangia di Santa Maria del Soccorso. La comunicazione tra le due cappelle sarà stata aperta dopo la cessione, come già detto, fatta dai confratelli di Santa Maria del Soccorso all’ospedale l’8 luglio 1563.
L’altare di Santa Lucia non aveva entrate, e si celebrava con le elemosine dei fedeli solo il giorno della sua festa.
Quell’anno erano procuratori l’u. i. dr Ottavio Pisano ed il medico Battista de Gennaro. In obbe-dienza alla bolla del papa Gregorio XIII del febbraio 1573, costoro dovevano presentare i conti del- la loro amministrazione al vescovo o ad un suo delegato. Per la verifica degli anni precedenti l’in- carico fu assegnato ai rettori Matteo (de) Nicastro e Minico (de) Gennaro, con potestà di condenna- re et liberare sui rendiconti da esaminare.
L’altare maggiore mancava della croce di legno, e quello di Santa Lucia di due candelieri anche di legno, e fu ordinato di provvedere entro quindici giorni e due mesi rispettivamente.
Per ultimo, sulla via del ritorno, fu fatta la visita alla chiesa di Santa Maria dell’Imperaviglia, beneficio semplice e senza cura d’anime. Pavimentata e con due campane efficienti, era consacrata come anche l’altare. Questo era ornato da un paliotto di aurobello, da due candelieri, dalla croce di legno, e dalla carta-gloria.
L’arredamento non poteva immaginarsi più misero : una pianeta di tela moresca, un messale, un calice con la coppa e la patena d’argento, ed un càmice con l’amitto ed il cingolo.
La cappellanìa era stata affidata al sac. Giannandrea de Alexandris, l’unico rettore della parrocchiale che percepiva due porzioni, con bolla dell’omonimo vescovo col quale era senz’altro imparentato (18).
Per le devozioni dei fedeli di Monteleone erano aperte al culto le cinque chiese annesse ai conventi delle comunità religiose all’epoca presenti nella città.
I primi ad insediarsi erano stati nel 1280 i Minori Francescani Conventuali (19). Nella chiesa, intitolata al loro fondatore San Francesco d’Assisi, ebbero il riconoscimento del privilegio perpetuo gli altari di San Bonaventura il 10 marzo 1582 ed un altro senza indicazione del santo titolare nel 1616 (20). Questa è chiamata del Rosario, dal titolo della confraternita che nel 1810 fu autorizzata a trasferire in essa la propria sede.
Seguirono nel 1433 gli Agostiniani Eremitani, che in seguito cambiarono in Sant’Agostino l’originaria intitolazione all’Annunziata della loro chiesa (21). I locali, che avevano resistito alle scosse del terremoto del 5-7 febbraio 1783 sono stati adibiti a carcere fino al 199 .
Vennero nel secolo successivo, l’anno 1521, i Minori Francescani Osservanti che si stabilirono nel convento dedicato a Santa Maria de Jesu (22). In una cappella con accesso dall’ampio atrio si riunivano gli iscritti alla confraternita dell’Immacolata Concezione fondata il 27 giugno 1580 (23).
Nella chiesa, dentro la quale erano erette le tombe della sua famiglia, il duca Ettore Pignatelli fece collocare le cinque statue marmoree che nel 1524 aveva commissionato allo scultore palermitano Antonello Gagini. Queste nel 1810 ebbero sistemazione nel duomo dedicato a Santa Maria Maggio-re ed al protettore San Leoluca. L’altare marmoreo eseguito nel 1608 per le tre statue (Madonna della Grazia, Santa Maria Maddalena e San Giovanni evangelista) che costituiscono il noto “trittico” fu addossato alla parete sul lato destro del transetto, e le altre due (Madonna col Bambino e San Luca evangelista) furono poste a destra ed a sinistra dell’altare dell’Immacolata sul lato dirimpetto.
L’anno 1946 nella chiesa di Santa Maria de Jesu, conosciuta con l’appellativo di Santa Maria la Nova, fu trasferita la parrocchia dello Spirito Santo.
Pochi ani dopo la loro fondazione, nel 1534 costruirono il loro convento i Minori Francescani Cappuccini, dedicando all’Annunziata la loro chiesa. La prima sede, che a causa dell’aria malsana abbandonarono poco più di un secolo dopo per trasferirsi in quella dove tuttora si trovano, era nei pressi dell’attuale Madonnella chiamata anche li Cappuccini vecchi.
Nel sedicesimo secolo gli ultimi ad arrivare furono i Domenicani. L’erezione del loro convento, deliberata in publico parlamento dai cittadini di Monteleone il 14 giugno 1543 (26), dopo l’ac- cettazione del duca Ettore Pignatelli signore della città, fu confermata dal pontefice Paolo III con bolla dell’8 febbraio 1544 (27).
Nella chiesa, sotto il titolo del loro fondatore San Domenico, erano erette le confraternite laicali della Madonna del Rosario e del Nome di Gesù.
Nel complesso, che ospitò prima l’orfanotrofio e poi l’istituto tecnico industriale statale, fino ad alcuni anni orsono erano allogati parte degli uffici della curia diocesana di Mileto.
La relazione della visita pastorale effettuata in meno di due giornate dal vescovo diocesano, seppure accuratamente compilata, non poteva contenere una completa trattazione della vita religiosa della città. Si rende necessaria l’integrazione di quelle prime informazioni, le prime e per tanti aspetti anche le uniche riunite in modo organico, con le altre che si possono rinvenire in diverse fonti sia archivistiche che bibliografiche.
L’itinerario del primo giorno non poteva essere diverso, essendosi svolto nel solo pomeriggio, come è evidenziato dall’annotazione che furono celebrati i vespri.
La prima chiesa visitata fu quella di San Michele per la presenza del Santissimo Sacramento, stante la disagiata ubicazione della parrocchiale nella quale, anche se in stato di colpevole abban-dono, era installato il fonte battesimale.
Reso il dovuto onore all’Eucaristìa, centro della vita spirituale di ogni credente, il vescovo si diresse verso Santa Maria la Grande, madre di tutte le chiese della città.
Rimangono non facilmente comprensibili due vistose omissioni, una chiesa ed un altare. L’esisten-za di entrambi è documentata sia prima che dopo la visita.
Nel verbale non si trova alcun accenno all’antica chiesetta di San Pietro eretta all’interno della cinta muraria dell’epoca angioina. Le descrizioni ottocentesche la dicono vecchio monumento di stile gotico o anche differente dallo stile del trecento per li ornati accessori che la decoravano (28). I suoi ruderi, con istrumento notarile del 3 novembre 1855, furono venduti al sig. Cesare Marzano (29).
L’altra omissione riguarda l’altare della Madonna della Grazia, di patronato della famiglia Soriano, eretto il 29 maggio 1488 nella chiesa di Santa Maria Maggiore (30). Risulta fra quelli visi-tati il 2 novembre 1630 dal vicario generale Lelio Lupari (31).
Osservando i dettagli, la prima considerazione riguarda le condizioni degli altari. Salvo poche eccezioni erano tutti mancanti dell’altaretto portatile meglio conosciuto come pietra sacra, e del crocifisso di legno. Solo in due c’erano le carte-gloria.
Nel verbale, degli altari laterali di ciascuna delle chiese di San Michele e di Santa Maria del Soccorso fu riportato il loro numero, con l’aggiunta per questi ultimi che non avendo rendite si celebrava a devozione dei fedeli. Per la loro individuazione non è di alcuno aiuto la successiva visita pastorale del 2 novembre 1630, già citata (32). Nella chiesa di San Michele soltanto di sei altari furono indicate le famiglie che ne detenevano il patronato. Impossibile persino il tentativo per Santa Maria del Soccorso, perché di altari ne furono elencati undici dal lato destro e dieci dal sinistro dell’altare maggiore.
In riferimento ai campanili c’è da tener presente che specie per le piccole chiese si trattava di una parete in muratura, o più facilmente d’alcune assi di legno, poste al centro o ad un lato del frontespizio per reggere una campanella che invitava i fedeli alla partecipazione alle funzioni liturgiche.
La presenza degli stendardi e l’esplicita dichiarazione che le confraternite partecipavano alle pro-cessioni che si facevano nella città mostra come quelle pìe adunanze non stavano ai margini della vita religiosa monteleonese. Però non fu specificato se le processioni erano soltanto quelle peni-tenziali (Settimana Santa, Rogazioni) e del Corpus Domini, od anche altre in onore della Madonna o dei santi dei quali esistevano le statue di legno.
L’assenza di qualunque accenno agli autori sia dei tanti quadri che delle poche statue impedisce di conoscere se la committenza era rivolta ad artisti locali oppure di fuori della regione. Purtroppo, nessuna di quelle opere è attualmente nelle dotazioni della chiese della città.
Infine, non si può fare a meno di qualche rilievo sulle rendite delle varie chiese di Monteleone in quell’anno 1586. La più ricca era di gran lunga la parrocchiale di Santa Maria Maggiore, seguita dalla chiesa di Santa Maria dell’Imperaviglia. Possedevano la prima oliveti e l’altra solo una mezza pianta d’olivo, ed entrambe terreni seminatori, come anche esigevano censi in grano, in olio, in cera ed in danaro.
Le condizioni sia delle chiese-edificio che delle chiese-templi spirituali, purtroppo, non erano in consonanza con le consistenze delle rispettive rendite patrimoniali.
Antonio Tripodi, Diacono
|